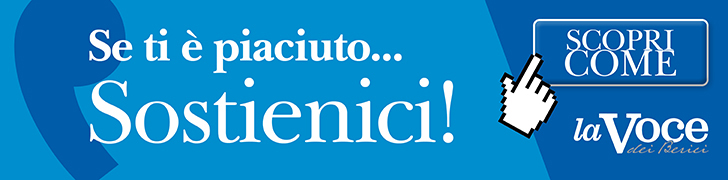Quarant’anni della legge che cambiò le campagne
Le norme possono essere un fattore determinante nei cambiamenti di un territorio e della società che lo abita. È stato così per la Legge Regionale n.40/85, di cui ricorrono i quarant’anni esatti dall’adozione. Si trattava di una norma in tema edilizio atta alla “tutela ed edificabilità delle zone agrarie”.
Tra le caratteristiche fondamentali, la possibilità di costruirsi una casa in un fondo rustico, se in quello stesso fondo ce n’era un’altra di proprietà della famiglia da almeno cinque anni. Venivano poste alcune condizioni fondamentali sulla cubatura, perché la nuova abitazione non poteva superare i 600 metri cubi complessivi e la somma definitiva dei due immobili si doveva fermare a 1200 metri cubi. E pure la metratura del fondo agricolo di partenza doveva attenersi a misure precise. Il tutto, con continui riferimenti alla normativa già esistente all’epoca e alle molteplici deroghe previste. Per esempio, la stessa cubatura poteva essere ampliata a 800 metri cubi una volta demolita la casa precedente se di proprietà da almeno sette anni. Come riportava la Voce dei Berici di allora, pertanto, i presupposti erano «talmente elastici che ogni famiglia rurale poteva mettere in piedi una casa per il figlio» che si sposa va, anche se quest’ultimo aveva un lavoro in città con mansioni ben diverse dall’agricoltore. La L.r. 40/85, del resto, era nata per garantire una forma di residenza a chi voleva farsi una famiglia e aiutava i genitori contadini nella loro attività. Con l’ulteriore fine, tuttavia, di preservare il verde e l’area agricola il più possibile.
A quattro decenni di distanza, in una situazione generale in cui la grande maggioranza dei veneti si ritrova va tra i beneficiari, sono stati rispettati questi obiettivi? Secondo l’esperto Salvatore Abbate, che per una vita intera ha seguito il settore urbanistico in più Comuni Vicentini (Recoaro Terme, Marostica, Bressanvido, Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Quinto Vicentino), la risposta è sì per quel che riguarda la residenzialità. No, invece, per la tutela del verde, perché avrebbe compromesso profondamente il territorio. «Si veniva da una situazione di caos regolamentare: molte amministrazioni municipali dovevano ancora approvare i rispettivi Piani Regolatori Generali (Prg); c’era già stato un condono per pochi soldi a livello nazionale, a cui se ne sarebbero aggiunti altri due nel 1994 e nel 2000. Il risultato è che si continuò a costruire in ordine sparso. E stavolta con una forte speculazione, perché ci fu la corsa ad accaparrarsi edifici esistenti in zona agricola accanto cui costruire la propria futura dimora. Senza dimenticare la facilità con cui si poteva portare la cubatura a 800 metri cubi complessivi. Sorsero così nuove villette ovunque».
Lo spirito originario della legge finì presto perduto. Aggiunge Abbate: «Qualcuno, grazie alle deroghe, realizzò persino piscine e campi da tennis che poi incorporò nei terreni di proprietà. L’urbanistica ha sempre forti implicazioni politiche, essendo un’arma di con senso». E specificamente nel Vicentino come andò? «La situazione di partenza era diversa, anche per la diversità delle aree al proprio interno tra montagna e pianura. Nella fascia montana, l’attività agricola si era già diradata dagli anni ’60 perché poco redditizia; al massimo, ci fu qualche acquisto di immobili da far diventare poi seconde case. Mentre nelle campagne della pianura, per la presenza della grande proprietà terriera e della mezzadria, non ci fu un frazionamento dei terreni così diffuso e il conseguente sorgere di cantieri edili ovunque. E così, più di qualche Comune, come Bressanvido, presenta ancora una riconoscibile conformazione agricola».
Roberto Turetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA