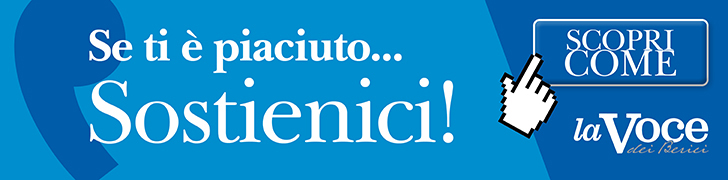Questo sabato si inaugura a Gubbio la mostra Francesco e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro. L’iniziativa si colloca nel contesto degli anniversari francescani che vanno dagli 800 anni della Regola (2023) a quelli della morte del poverello (2026), passando quest’anno per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, capolavoro della letteratura italiana e sintesi mirabile della spiritualità “ecologica” del santo di Assisi. Per quanto si tratti di uno dei fioretti più ricordati e rappresentati, è la prima volta che un’intera mostra viene dedicata all’episodio del lupo di Gubbio. Le fonti francescane raccontano di come Francesco, armato solo della sua profonda fede e della convinzione che tutte le creature di Dio fossero vocate ad una convivenza pacifica e armoniosa, riuscì ad avvicinare incolume il lupo feroce che terrorizzava gli abitanti di Gubbio seminandovi razzia e morte. Il poverello, come già altre volte aveva dato prova di saper fare, trovò il modo di comunicare con l’animale e lo ammansì, convincendolo a smettere di nuocere alla gente e assicurandogli che gli stessi abitanti della città lo avrebbero sfamato ogni giorno e si sarebbero presi cura di lui. Il lupo, da quel momento in poi, visse in pace con i cittadini di Gubbio fino alla fine dei suoi giorni.
Sull’episodio si è molto discusso, proponendone anche interpretazioni di tipo allegorico. Secondo alcuni il “lupo di Gubbio” non sarebbe stato un animale feroce, ma un pericoloso brigante che dopo aver commesso molti furti e atrocità si sarebbe convertito grazie alla predicazione e all’amicizia di Francesco. Bisogna però ricordare che nel 1873, durante alcuni lavori nella cripta della chiesa di San Francesco della Pace, venne ritrovata una piccola lapide altomedievale che ricopriva i resti di un canide, successivamente identificato con lo scheletro di una lupa. Circostanza affascinante che comproverebbe la leggenda antica, soprattutto perché, per quanto ci è dato di sapere, risulta ad oggi l’unico caso di un animale sepolto all’interno di una chiesa, con tanto di pietra tombale ornata di croce.
Quello che, in ogni caso, questo racconto trasmette è la fiducia nella possibilità della convivenza pacifica e della fraternità tra tutte le creature, uomini o bestie che siano. Una fraternità che si fonda, però, sulla disponibilità all’incontro, alla comprensione e alla cura reciproca, senza i quali i rapporti si fanno inevitabilmente conflittuali e l’altro è percepito come nemico e prevaricatore. Homo homni lupus, per citare l’espressione di Plauto poi ripresa con successo dal pragmatismo filosofico (e anticristiano) di Thomas Hobbes. Francesco riesce ad ammansire la ferocia del lupo avvicinandosi a lui come amico e assicurandogli che alla sua fame avrebbero pensato gli abitanti della zona. La tomba (indicata anche dalla toponomastica antica del sito, Trivio morlupi, cioè “incrocio della morte del lupo”) dice di un rapporto di affezione reciproca subentrata a quel patto miracoloso e dunque non solo di scelte dettate da opportunismo politico.
L’episodio di Francesco e il lupo ci ricorda come ogni giorno dobbiamo decidere con quali occhi guardare a chi ha idee diverse dalle nostre, a chi ci pesta i piedi, a chi ostacola i nostri desideri e progetti, perfino a chi compie il male, seminando, menzogna distruzione e morte. Dobbiamo decidere se vogliamo vivere in un mondo di nemici, di posizioni contrapposte e di polarizzazioni sempre più violente e velenose o se, come Francesco, vogliamo correre il rischio di andare incontro al lupo e di guardarci negli occhi, in cerca di quella scintilla di Dio che – come cristiani ne siamo convinti e lo ribadiamo anche a costo di essere considerati degli ingenui o degli illusi – deve esserci ancora, anche nello sguardo divenuto più opaco e tenebroso e grazie alla quale, crediamo, ci sia sempre la possibilità di un nuovo inizio. Senza dimenticare che lupi, magari senza accorgercene, potremmo essere divenuti per qualcuno pure noi.
donalessio@lavocedeiberici.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA