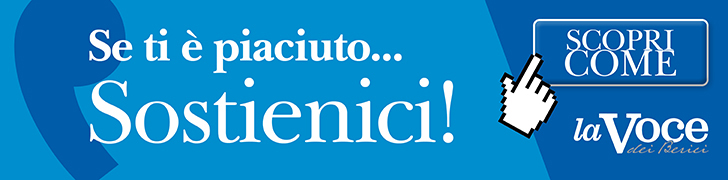Se ne sta facendo in questi giorni un gran discutere e, come spesso accade in politica, anche questa volta pare difficile darne, da semplici cittadini, una valutazione oggettiva. Ciò che per la destra è ottimo, per la sinistra è pessimo, e viceversa.
La riforma costituzionale che porterebbe a definire la separazione delle carriere all’interno della Magistratura produrrà finalmente un miglioramento degli iter giudiziari, garantendo maggiore equità nei processi, o viceversa è un provvedimento inutile che andrà solo a indebolire l’autonomia del potere giudiziario a favore di quello esecutivo, affievolendo le garanzie democratiche nel nostro Paese?
In un prossimo eventuale referendum confermativo, votare SÌ significherà rafforzare il potere del Governo, limitando quello dei giudici, o sarà l’avvio della riforma di un sistema che oggettivamente non gode di buona salute?
Sui timori espressi dalla sinistra di una possibile manomissione indiretta dell’equilibrio tra i tre poteri equipollenti (legislativo, esecutivo e giudiziario), su cui si fondano tutti gli Stati democratici e su cui venne costituita la nostra Repubblica dopo il ventennio fascista, sembrano in realtà pesare più le grida che negli ultimi decenni tutti i leader della destra hanno lanciato contro la Magistratura, che non lo specifico oggetto del contendere.
In Italia, da sempre, si sa, se piove è colpa del Governo, che a sua volta accusa i Giudici e ultimamente molto anche quei burocrati cattivi della Pubblica Amministrazione, sempre pronti a mettere i bastoni tra le ruote (o tra le arcate dei ponti).
Farne una questione di appartenenza politica sarebbe, però, almeno in questo caso, del tutto fuorviante.
Infatti, se è vero che l’Associazione Magistrati si è già espressa per il NO con una nota durissima in cui afferma che, se dovesse passare, questa riforma renderebbe la giustizia “meno libera, più esposta all’influenza dei poteri esterni e meno capace di difendere i cittadini”, producendo una Magistratura “forte con i deboli e debole con i forti”, d’altro canto troviamo politici e giuristi posizionati, per appartenenza o formazione, dove proprio non te lo aspetteresti: come Emma Bonino e Antonio Di Pietro a favore, o Franco Coppi, già legale di Berlusconi, e il renziano Ernesto Carbone contrari alla riforma.
Certamente, di “separazione delle carriere” nella Magistratura si parla in Italia da almeno trent’anni, tanto che i più autorevoli manuali di Diritto costituzionale la annoverano come oggetto di studio, definendola una “questione tormentata”.
La Costituzione italiana indica come membri della Magistratura tanto i pubblici ministeri (definiti organi “requirenti”) quanto i magistrati giudicanti (i giudici ordinari), rendendo così possibile il passaggio di un magistrato da una “carriera” all’altra senza particolari difficoltà.
Tale appartenenza a una medesima categoria professionale, secondo una corrente critica – come detto bipartisan – porterebbe a un’inopportuna “familiarità” tra giudice e accusa, che facilmente potrebbe volgersi a scapito del soggetto imputato.
La riforma prevederebbe pertanto di separare nettamente le due categorie di magistrati, impedendo il passaggio dall’una all’altra, istituendo due concorsi distinti (e quindi verosimilmente anche percorsi formativi differenziati), ma anche sdoppiando il Consiglio Superiore della Magistratura e scorporandone i poteri disciplinari, che verrebbero affidati a un’apposita Alta Corte.
Sulla composizione di tali organi di controllo peserebbe maggiormente, rispetto alla prassi attuale, l’influenza del Parlamento, secondo un meccanismo tipico delle repubbliche presidenziali.
Da evidenziare che i magistrati che negli ultimi cinque anni hanno cambiato funzione, passando da requirenti a giudicanti o viceversa, sono stati appena lo 0,3% del totale e che altri dati statistici diffusi dall’Associazione Magistrati dimostrerebbero come l’appartenenza allo stesso ordine professionale di giudici e pm non andrebbe, per forza di cose, a condizionare la formulazione delle sentenze.
Quello che fa la differenza sarebbe (come sempre) solo l’intima onestà — o disonestà — del giudice.
Pare dunque lecito porre il dubbio sugli effetti di una tale riforma sulla giustizia italiana, le cui fatiche sono imputabili piuttosto a un’ormai strutturale carenza di organico, a fronte di un sempre maggior numero di reati contestati.
Alessio Graziani, donalessio@lavocedeiberici.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA