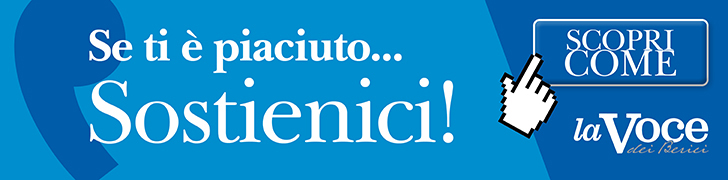«Resistente, per tutta la vita». È la descrizione di Tina Anselmi nella sintesi della storica vicentina Alba Lazzaretto. L’autrice – accademica olimpica e vicepresidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza, già professoressa di Storia contemporanea all’ateneo padovano – ha da poco dato alle stampe “Tina Anselmi. La donna delle riforme sociali”, edito da Prometheus. Un saggio che mette nero su bianco quello che forse mancava, la biografia di una grande italiana. Anselmi – trevisana di Castelfranco, classe 1927 – fu giovane maestra e giovanissima partigiana, poi sindacalista e attivista a favore delle operaie delle filande, parlamentare Dc e prima donna italiana alla guida di un ministero. Mossa dall’agire cristiano e dal senso di giustizia, si devono a lei alcune norme fondamentali della Repubblica: quella sulle pari opportunità ed equiparazione salariale sul lavoro, nel 1977, e la fondamentale riforma della sanità pubblica, nel 1978.
Professoressa Lazzaretto, perché ha iniziato questa ricerca?
«E’ un libro che è nato per iniziativa del Centro Italiano Femminile di Roma quando, qualche anno fa, la presidente Renata Natili Micheli mi ha chiesto di scrivere la biografia della prima donna Ministra nella storia italiana. Le risposi, ci provo… Non sapevo che non esisteva un archivio».
Lei è andata subito alla ricerca delle fonti, cosa ha trovato?
«Le “fonti”, quelle più importanti – carteggi, diari, appunti scritti di pugno da Tina Anselmi – si rivelarono un tesoro quasi introvabile. Non esisteva alla Camera dei deputati un archivio Anselmi e i documenti che Tina stessa consegnò all’Archivio storico dell’Istituto “Luigi Sturzo” erano in gran parte secretati. Sono i documenti che riguardano il suo lavoro sulla loggia P2. L’archivio ha deciso di non renderle disponibili in quanto ritiene contengano notizie sensibili su persone ancora viventi».
Come ha fatto, allora?
«Ho deciso di partire dalla ricostruzione dell’ambiente di formazione di Tina a Castelfranco: famiglia, parrocchia, Azione cattolica, figure di riferimento ideale, capi e fiancheggiatori della Resistenza, le basi ideali su cui si era formata. Ripercorrendo poi, in base agli studi editi, la vita di Tina negli anni del dopoguerra: l’attività sindacale, lo studio presso l’Università Cattolica di Milano, l’insegnamento».
Che immagine le ha restituito della Anselmi?
«Appunto, una donna resistente per tutta la vita. Dignitosa, fiera, tesa verso la giustizia. Una donna che seppe trasporre in forma politica la carità cristiana imparata fin da bambina».
Qual è l’ambiente in cui si forma?
«Era molto credente, ma aveva un padre apertamente socialista che per questo venne picchiato dai fascisti. C’era una persona del paese, il fratello anarchico della sua maestra, che lei ammirava. E aveva i punti di riferimento della madre e della nonna: diceva di assomigliare soprattutto alla nonna, una donna intraprendente che, rimasta presto vedova, non si era persa d’animo e aveva saputo aprire un’attività crescendo i tre figli».
Crebbe durante il ventennio fascista.
«Lei stessa scriveva: andavamo alle lezioni di fascismo e lo imparavamo a memoria, punto. Il fascismo era lontano dalla mentalità cattolica. Se pensi che sono importanti l’aiuto, la carità, la mitezza, allora boria, vanagloria e volontà di potenza ne sono agli antipodi».
Perché, appena diciassettenne, scelse la Resistenza?
«Quando, studentessa a Bassano, fu costretta ad assistere all’impiccagione degli innocenti rastrellati sul Grappa, per lei fu il “colpo di grazia”. Ma nel suo cuore aveva già scelto da tempo. Era una donna tesa verso la giustizia sociale e vedeva la Rsi come un qualcosa che ammazzava gli altri italiani. Intorno aveva esempi di persone che si opponevano al fascismo: dal suo insegnante di religione, al vescovo di Vicenza Rodolfi, al vescovo di Treviso, fino a suo padre».
Nel dopoguerra si laurea alla Cattolica di Milano, ma fa anche sindacato.
«Prima con la Cgil, poi – non appena si costituì – con la Cisl. A guerra finita, Anselmi da subito esplica il desiderio di giustizia lottando per le filandine, che rischiavano il licenziamento per la concorrenza delle sete giapponesi. Erano donne che, fino a quel momento, ignoravano ogni rivendicazione. Lei le assiste, e litiga con i sindacati di sinistra che la rimproverano per accettare dei patti in cui le operaie accettano delle ore di lavoro in più allo stesso stipendio, pur di non perdere il posto. Il suo era un sindacalismo moderato e di buon senso, mentre socialisti e comunisti pensavano a lotta e rivoluzione. Fu comunque sempre una democristiana atipica, non inquadrata in nessuna corrente ma vicina ad Aldo Moro: la chiamavano la “Tina vagante”».
Come continuò il suo percorso politico?
«Si fece grande esperienza a Roma con altre donne di alto profilo e parlamentari, anche di altri partiti: Angela Guidi Cingolani, Maria de Unterrichter Jervolino, Maria Eletta Martini, Franca Falcucci. Lina Merlin, Nilde Jotti. Lì, stava vicina alle prostitute: comprava loro le macchine da cucire, perché imparassero a mantenersi da sole. Portò avanti il movimento femminile della Dc. In generale si fece una forte cultura politica, entrando in Parlamento nel 1968 e rimanendoci fino al 1992».
Quali obiettivi raggiunse?
«La legge sulla Sanità fu la sua opera più importante. Giaceva in Parlamento da 14 anni e aveva incontrato ostacoli di ogni tipo, da parte dei medici e delle case di cura. Anselmi riuscì a portarla a compimento, litigando praticamente su ogni passaggio: un’impresa enorme. La norma pose l’Italia all’avanguardia tra i Paesi europei in fatto di welfare sanitario. Purtroppo fu in molti casi disattesa, come dovette amaramente constatare Tina parecchi anni dopo. E poi, non si può certo tacere l’ardua esperienza di presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, che attirò su Tina molte inimicizie, ritorsioni, dispiaceri. Si fece un mare di nemici: perché lei voleva andare avanti, andare fino in fondo. Pagò un duro prezzo per essere stata onesta e imparziale. Nel 1992 la DC non la candidò nel “suo” collegio di Venezia-Treviso, ma la presentò in un collegio difficile, quello di Conegliano-Oderzo. Dove era in ascesa la Lega e dove c’erano un sacco di amici di Licio Gelli e della P2. Tina ne uscì perdente».
Eppure, gli italiani in qualche modo se ne rammaricarono e la ringraziarono per il suo impegno.
«Questo è il contenuto più completo e originale del volume. Tina ricevette oltre 350 lettere, spontanee, da tutta Italia. Testimoniano quanta fosse la stima che Anselmi si era meritata tra la gente, soprattutto da coloro che avrebbero dovuto essere suoi “avversari” politici. In molti raccolsero firme anche per proporla come candidata alla Presidenza della Repubblica. Nel libro le lettere sono ampiamente citate: l’intero volume è un omaggio a lei, ma anche a tutti coloro che come lei vogliono difendere giustizia e libertà».
Andrea Alba